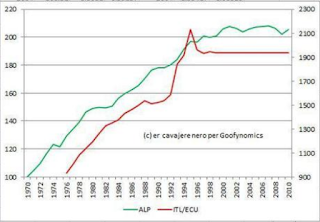Ormai da diversi
anni, un tema oggetto di intenso dibattito è la stagnazione delle produttività
che l’economia italiana ha sperimentato in prossimità dell’ingresso nell’euro,
e ancora di più successivamente.
Sul tema si è espresso
tra gli altri Alberto Bagnai, constatando che in Italia, da metà degli anni Novanta, la
crescita della produttività reale del lavoro (linea ALP) si è sostanzialmente arrestata, in
corrispondenza con l’”aggancio” della lira a quello che sarebbe poi stato il
cambio d’ingresso nell’euro (1936,27, e 990 contro marco).
Più di recente, Guido
Iodice ha fatto notare che il grafico di Bagnai mette in correlazione la crescita
della produttività con il cambio nominale lira / marco. Questo, nota Iodice, è inesatto
perché il confronto va fatto con il cambio reale (cioè con il cambio corretto per
tener conto delle differenze di inflazione tra Italia e Germania).
Effettivamente,
se confrontiamo produttività e cambio nominale (il “grafico Bagnai”, il primo sopra
riportato) si nota che la produttività italiana ristagna, sostanzialmente, a
partire dal momento in cui il cambio con la Germania si blocca, mentre in
precedenza le due curve salivano all’incirca di pari passo.
Ma se
confrontiamo produttività e cambio reale (il “grafico Iodice”) si notano
fenomeni differenti. La produttività italiana ha continuato a salire sia in
anni in cui il cambio reale si rafforzava (1976-1992) sia successivamente alla
rottura dello SME, quando si è (fine 1992-1994) fortemente indebolito.
Per far luce sul
tema, è utile prendere in considerazione la legge di Kaldor-Verdoorn, secondo
la quale la produttività tende a salire in funzione del prodotto fisico di un sistema economico.
La ragione è intuitiva. Se un’economia
cresce, ci sono più risorse a disposizione, e più incentivo ad investirle in
nuovi impianti e tecnologie più avanzate. E ci sono anche maggiori economie di
apprendimento – più si fa, e meglio s’impara a fare, banalmente detto.
Fino all’avvento
dell’euro, la crescita reale dell’economia italiana è stata soddisfacente, in
linea con le medie europee. E la produttività è aumentata di pari passo. Qui un
altro ben noto grafico di fonte Bagnai mostra il graduale avvicinamento del PIL
procapite italiano rispetto alle medie UE15 tra il 1970 e metà degli anni
Novanta (e la drammatica successiva inversione di tendenza).
Il rafforzamento
del cambio reale del periodo precedente al 1992 non ha rallentato la crescita
italiana, ma ha deteriorato le partite correnti e in particolare il saldo commerciale
estero. Negli anni tra il 1980 e il 1992, periodo nel quale il cambio reale
italiano si rafforzava, le partite correnti in percentuale del PIL sono state
mediamente passive in misura pari all’1,5% circa, e del 3% nel 1992 – anno in
cui l’Italia è stata costretta ad abbandonare lo SME.
Il riallineamento
valutario si è accompagnato a un’inversione di segno delle partite correnti,
fino a un surplus del 2,5% circa nel 1996. Di pari passo all’”aggancio euro” si
è poi avuta una riduzione di questo surplus, fino a raggiungere una sostanziale
parità intorno al 1998-2000.
Partite correnti
in equilibrio, in situazione di domanda interna italiana a livelli normali (non
euforici né depressi), implicano che il cambio di ingresso nell’euro non era,
almeno inizialmente, “sbagliato”.
La crescita
italiana ha rallentato in quegli anni, ma l’indiziato principale non è il
cambio bensì l’adozione di politiche economiche restrittive, finalizzate a rientrare
nei parametri del trattato di Maastricht: in particolare, con riferimento a
inflazione e rapporto deficit pubblico / PIL.
A questo punto
il rallentamento della crescita ha prodotto la stagnazione della produttività.
Nel frattempo la Germania guadagnava non tanto in termini di produttività, ma
di competitività – attuando politiche di forte contenimento salariale.
L’Italia è
quindi entrata in un circolo vizioso. La combinazione di politiche economiche
restrittive, di stagnazione della produttività e di peggioramento della
competitività ha agito negativamente sulla domanda, sulla crescita e di
conseguenza (Kaldor – Verdoorn) ha ulteriormente penalizzato la produttività.
La crisi
finanziaria del 2008 ha ulteriormente enfatizzato questa situazione negativa. E
l’austerità adottata dal 2011 in poi, in diretta conseguenza della crisi dei
debiti sovrani, ancora di più.
Il nesso tra
euro e stagnazione della produttività quindi esiste ed è estremamente
significativo, ma per ragioni più variegate rispetto a una semplice causazione cambio
sopravvalutato ==> ristagno della produttività.
L’euro ha svolto
un ruolo in quanto:
UNO, la
necessità di rispettare i parametri di Maastricht ha costretto l’Italia ad
adottare e mantenere politiche fiscali restrittive.
DUE, i guadagni
di competitività tedeschi in un regime di monete nazionali e cambi flessibili
sarebbero stati, con ogni probabilità, gradualmente compensati dalla
rivalutazione del marco contro la lira. Questo non è avvenuto, ed ha
ulteriormente penalizzato la crescita italiana.
Ma:
TRE, l’euro
entra ancora di più in gioco a partire dal 2011, in quanto le tensioni e gli
squilibri commerciali tra Nord e Sud dell’Eurozona hanno fatto temere che
potesse verificarsi la rottura della moneta unica. Questo ha portato, tra le
altre cose, al calo di valore dei titoli di stato sudeuropei rispetto a quelli
dell’ex area marco, quindi all’innalzamento degli spread sui tassi d’interesse.
Quanto sopra è
una diretta conseguenza dell’euro, in quanto la pressione al ribasso sul valore
dei titoli di stato sud-eurozonici avrebbe preso la forma – in regime di debiti
espressi in monete nazionali, e di cambi flessibili – di un indebolimento del
cambio (che tra l’altro sarebbe stato un fattore di riequilibrio dell’economia
reale) e non della salita degli spread.
Peggio ancora,
come condizione per i sostegni forniti dalla BCE ai debiti pubblici del Sud,
sono state richieste forti restrizioni fiscali (l’austerità) in una situazione
in cui la domanda non aveva ancora recuperato gli effetti della crisi Lehman: ulteriore
pesante impatto negativo sul PIL e sulla produttività.
Tutto questo non
assolve i governi italiani (né le autorità UE) dall’imputazione di aver
commesso vari e gravi errori nell’impostazione delle politiche economiche degli
ultimi quindici anni.
Anche in
presenza dell’impossibilità di riallineare il cambio, l’Italia avrebbe potuto adottare politiche di riequilibro della competitività nei primi
anni dell’euro, non necessariamente comprimendo i salari ma ad esempio
riducendo il cuneo fiscale (e utilizzando a tal fine uno sforamento dei vincoli
di Maastricht nel periodo – principalmente 2002-2004 - in cui sforava la
Germania).
E soprattutto,
nel 2011 (1) Monti non avrebbe dovuto accettare l’adozione di livelli di
austerità così massicci (sotto forma principalmente di imposte su patrimonio e consumi e di tagli di spesa pensionistica) e (2) nella misura in cui questi interventi fossero stati attuati, almeno in
parte si sarebbe dovuto utilizzarli (anche qui) per ridurre il cuneo e quindi
il costo del lavoro lordo per le aziende.
E’ comunque
indubbio che l’euro, o più propriamente i vincoli dell’Eurosistema e l’insieme
delle politiche adottate per cercare, in qualche modo, di evitarne la rottura,
hanno una stretta relazione con il declino della produttività italiana.
La soluzione
passa dall’uscita da questi vincoli. Il che si attua mediante politiche
espansive della domanda, abbinate a un miglioramento della competitività delle
aziende (per evitare l’insorgere di squilibri commerciali esteri).
Miglioramento della competitività che, anche in presenza dell’impossibilità di
riallineare il cambio, può essere ottenuto con una forte riduzione di
contributi e oneri a carico delle aziende.
Il progetto CCF è una strada possibile per ottenere questi risultati: uno strumento monetario
parallelo – i Certificati di Credito Fiscale – con cui effettuare azioni di
spesa pubblica, trasferimenti ai privati, e assegnazioni alle aziende in
funzione dei costi di lavoro da esse sostenuti (riducendo di conseguenza il
costo del lavoro effettivo).
La rottura della
moneta unica e il conseguente riallineamento valutario non è quindi l’unica
modalità possibile attraverso cui risolvere l’Eurocrisi. Ma l’uscita dai
vincoli dell’Eurosistema (nella sua impostazione attuale) è assolutamente
indispensabile.
Con la ripresa
di domanda, PIL e occupazione, tutto lascia pensare che riprenderà a salire
anche la produttività delle aziende italiane. La legge di Kaldor-Verdoorn funziona
in entrambe le direzioni.
Il ristagno
della produttività italiana non deriva da discontinuità tecnologiche, da
sconvolgimenti geopolitici, dall’inadeguatezza della classe imprenditoriale
italiana. Niente di tutto questo. E’ la conseguenza di un sistema di governance
economico-monetario sbagliato, e delle politiche errate e insostenibili con cui
prima lo si è introdotto, e poi si è cercato di rabberciarne le
disfunzionalità.